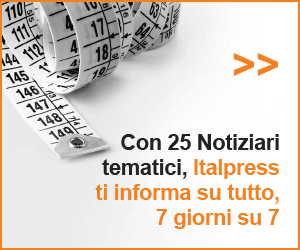Una scintilla per l’autocoscienza delle donne afghane. È così che una delle organizzatrici della campagna #WhereIsMyName definisce lo spirito dell’iniziativa che ha nel riconoscimento dell’identità primaria il suo obiettivo primario.
Alle donne dell’Afghanistan viene infatti negato il diritto di poter essere nominate e di conseguenza di poter esistere come individui liberi. Nemmeno sulle lapidi, sulle partecipazioni ai matrimoni o persino sulle prescrizioni mediche è concesso loro di avere un nome.
I giovani promotori della campagna spiegano infatti che, ancora oggi nel 2017, per le donne vengono quasi sempre utilizzati degli pseudonimi: la mia capretta, la madre dei miei figli, la mia parte debole. Si tratta di un evidente riflesso dell’antica tradizione patriarcale del paese che l’iniziativa vuole definitivamente archiviare.
L’hashtag è stato tradotto nei dialetti locali: “È come una scintilla — dice Bahar Sohaili, una delle organizzatrici al New York Times — che spinge le donne a chiedersi perché viene loro negato un diritto primario”. Tahmina Arian, 26 anni, spiega a France Presse: “Ho deciso di partecipare perché sono stanca di vivere nel Medioevo quando siamo nel XXI secolo”.
La campagna è partita a Herat e ha già coinvolto artisti, deputati e membri del governo: “La nostra società è ultraconservatrice e un uomo può provare vergogna a chiamare la moglie per nome”, ha detto alla France Presse Mohammad Amir Kamawal, professore di scienza sociali all’Università di Kabul.
“Il Corano non dice da nessuna parte che le donne non devono essere chiamate per nome” puntualizza Kamawal che quindi esclude la componente religiosa. “Nella logica tribale – aggiunge al New York Times Hassan Rizayee, sociologo – è importante chi possiede il corpo, la faccia e il nome della donna”.
Come sempre non sono mancate le polemiche e le critiche. Su tutte quelle di Modaser Islami che dirige un’organizzazione giovanile: “Il nome di mia madre, mia sorella o mia moglie sono sacri come il loro velo. È un segno del loro onore”, ha detto al New York Times. .