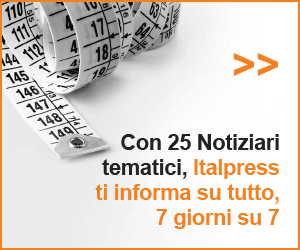Sembra chiaro che la democrazia sia oggi in crisi in molte parti del mondo. Guardiamo solo a quello che è successo in questo mese di luglio: in Turchia è in corso il processo spettacolo ai danni dei giornalisti dell’importante quotidiano Cumhuriyet, in Russia Vladimir Putin ha messo al bando i network virtuali privati usati dagli attivisti pro-democrazia per sfuggire alla censura di stato, nella Cina comunista la Apple ha obbedito alla perentoria richiesta del governo cinese di ritirare dal mercato locale tali network.
Poi c’è la campagna del governo ungherese tesa a mostrare i partiti di opposizione e le Ong come pupazzi nelle mani del miliardario statunitense George Soros; in Polonia il governo sta mettendo in crisi l’indipendenza del potere giudiziario. In Venezuela frattanto continua, in un clima ormai da guerra civile, la stretta autoritaria da parte del presidente Maduro.
Infine, nel paese per lungo tempo considerato il più brillante esempio di una democrazia matura, gli Usa, il neopresidente Donald Trump mostra preoccupanti tendenze autoritarie e nella sua amministrazione regnano caos, improvvisazione e dilettantismo. Malgrado i segni evidenti di una crisi della democrazia a livello mondiale, è impressionante constatare come molte poche persone se ne preoccupino.
Si tende a non notare il trend globale, a vedere solo i propri problemi nazionali. Così, gli americani si preoccupano quasi esclusivamente di Trump, mentre diplomatici e politici europei esprimono cautamente il proprio dispiacere sulle preoccupanti tendenze autoritarie in Turchia, Polonia e Ungheria. Tornano in voga, come negli anni trenta i “nemici del popolo” di memoria fascista e sovietica: il miliardario e filantropo americano George Soros in Ungheria, la stampa liberal anti Trump negli Stati Uniti, il poeta dissidente Liu Xiaobo in Cina.
Turchia e Stati Uniti sono due casi di studio particolarmente interessanti. In Turchia Erdogan ha fatto licenziare decine di migliaia di professori universitari dissidenti, ha revocato loro il diritto di viaggiare all’estero, e ne ha anche gettato in carcere alcune centinaia. Per non parlare della repressione del giornalismo turco non allineato alle posizioni del suo partito AKP.
Negli Usa Trump sta dando battaglia alle cosiddette “sanctuary cities”, quelle città americane (circa 300) che in maniera totalmente legale hanno preso l’impegno di non collaborare con l’Agenzia Federale dell’Immigrazione. La settimana scorsa l’amministrazione Trump ha minacciato di ritirare i fondi federali che sostengono i sistemi giudiziari locali di queste città, mossa che le getterebbe nel caos.
Il presidente Usa ha sostenuto, parlando davanti a un gruppo di propri sostenitori in Ohio, che il governo federale sta “liberando” le città americane da bande di giovani immigrati criminali, impressionando il proprio uditorio con notizie non verificabili su orribili torture che queste bande praticherebbero su giovani ragazzine. La criminalizzazione di intere categorie di persone come gli immigrati e più in generale le tendenze autocratiche di alcuni leaders non sono nulla di nuovo nella storia americana e mondiale; la novità è che oggi, in giro per il mondo un gruppo di leaders democraticamente eletti stanno contemporaneamente svuotando di senso la democrazia nei propri paesi.
Si pensi a Putin in Russia, Erdogan in Turchia, Orban in Ungheria, Trump negli Stati Uniti, Maduro in Venezuela, Duterte nelle Filippine, Modi in India. Oggi poi, soprattutto a causa dell’avvento di Trump alla Casa Bianca e della crisi del progetto europeo, non c’è alcun grande paese pronto a fissare degli standard globali positivi per la democrazia.
Dopo la fine del comunismo in Europa Orientale nel 1989 e il collasso dell’Urss due anni dopo, il politologo americano Francis Fukuyama proclamò con certezza che era arrivata l’era della “fine della storia” e che i sistemi democratici avrebbero trionfato dappertutto. Ottimismo prematuro?