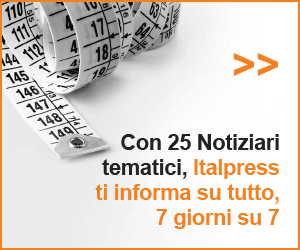Il 26 aprile si è commemorato in Ucraina il trentennale della catastrofe nucleare di Chernobyl, quando i tecnici della centrale persero il controllo della temperatura del reattore numero 4 che collassò liberando una nube radioattiva che si disperse sui cieli di tutta Europa. L’incidente è stato classificato a livello 7, il più alto nella scala internazionale degli incidenti nucleari. Circa 130 mila persone che vivevano nella città di Pripyat e nei villaggi in un raggio di 30 km vennero evacuate. L’accesso alla zona è tuttora controllato; agricoltura ed allevamento sono vietati ai pochi abitanti che hanno deciso di restare. Il reattore è sepolto sotto un sarcofago di cemento, che mostra segni di cedimento: ne sarà costruito un altro per contenerlo e mettere al riparo da ulteriori fughe di materiale radioattivo.
L’area contaminata è monitorata dalla comunità scientifica, interessata a comprendere gli effetti di lungo termine dell’elevato tasso di radioattività. Le osservazioni danno un quadro meno chiaro ed univoco di quanto si possa pensare. Innanzitutto, il numero delle vittime potenziali dell’incidente è stimato in modo sostanzialmente diverso da organizzazioni differenti: il Forum di Chernobyl, guidato dall’Onu, stima in 9000 le future morti per cancro, affermando peraltro che gli effetti di lungo termine sulla popolazione siano più di natura economica e psicologica che di salute o ambientali. D’altro canto Greenpeace stima una mortalità futura dieci volte maggiore, che porterebbe il bilancio totale a 200 mila morti. L’effetto più visibile sinora osservato è l’aumento dei casi di cancro alla tiroide, sino a 4000 casi; ma si tratta un male curabile e solo 15 malati sono morti. Tuttavia, Greenpeace stima che si potrebbe arrivare sino a 60mila casi di cancro alla tiroide su un totale di 270 mila casi di cancro.
Il deserto nucleare, scenario abituale di tanti film apocalittici, non esiste a Chernobil; anzi, la natura si è riappropriata dei centri urbani più rapidamente di quanto si possa pensare. Il fotografo Jon Brack, arrivato per documentare l’aspetto dell’area contaminata a 30 anni di distanza, racconta di aver chiesto alla sua guida quanto mancava per Pripyat: si è sentito rispondere che erano già in città. L’area abbonda anche di vita animale: orsi, lupi e renne sono ritornati nella zona, mentre uccelli fanno i nidi nei pressi del sarcofago del reattore. Anche la lince, da tempo scomparsa, è stata avvistata. Il numero di lupi, cui si dà la caccia per proteggere gli allevamenti nelle zone circostanti, è aumentato di sette volte ed ha eguagliato quello delle zone incontaminate nei paraggi. Gli scienziati sono sorpresi dal fatto che l’elevato livello di radiazioni non abbia effetti visibili sulla fauna; alcuni hanno osservato che il disastro nucleare ha avuto minori effetti sull’ambiente della normale attività umana. Non appare evidente, infatti, che l’eco-sistema sia stato danneggiato nel profondo.
Comunque, alcuni effetti sono ben visibili. La foresta di Chernobil è chiamata la “foresta rossa” perché i pini hanno perso la clorofilla a seguito dell’esposizione nucleare. Inoltre, è stato osservato che il legname ed il fogliame che ricopre il suolo della foresta, imputridisce molto lentamente. Gli esperimenti di Tim Mousseau, dell’Università della Carolina del Sud ed Anders Møller dell’Università di Paris-Sud, hanno mostrato che il fogliame nella zona radioattiva si decompone due volte più lentamente del normale. Questo comporta un maggior rischio d’incendi – e ve ne fu uno di grandi proporzioni nel 1992 – che spargerebbero elementi radioattivi con le volute di fumo. Inoltre, la rallentata decomposizione priva la foresta di minerali essenziali e frena la crescita di nuovi alberi; anche questo è stato verificato sul campo. Insomma, le radiazioni hanno effetto anche sui microrganismi deputati alla decomposizione e gli effetti in tempi lunghi di questo fenomeno sono imprevedibili.