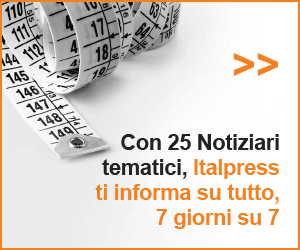Steven Sotloff, come il cattolico James Foley, l’altro giornalista americano decapitato dall’Isis, faceva parte di una famiglia sopravvissuta alla Shoah. Era andato in Medio Oriente attirato dalla complessità della religione.
31 anni, nato e cresciuto in Florida, Steven Sotloff aveva fatto per anni il freelance prima di essere rapito: aveva scritto da Siria, Egitto, Libia, Turchia e Barhain per testate come Time, il Christian Science Monitor, Foreign Affairs e World Affairs Journal.
I suoi colleghi lo ricordano per il carattere amabile, gli amici per la sua totale assenza di presunzione. A chi gli chiedeva che mestiere facesse, non diceva “giornalista di guerra”, ma “viaggiatore”.
Il suo sequestro, secondo altri colleghi, sarebbe stato frutto di un tragico capriccio del destino: Steven sarebbe stato rapito perché aveva scelto come collaboratore locale per entrare in Siria una “guida”, la cui identità però era stata “bruciata” con i rapitori da un altro reporter straniero, senza esperienza, intenzionato come lui a varcare il confine tra Turchia e Siria. Sotloff era stato preso in ostaggio nell’agosto 2013, la guida siriana, rapita con lui, era stata liberata due settimane più tardi.
Sotloff amava il mondo islamico e nei suoi reportage si era spesso concentrato sul lato umano dei conflitti mediorientali, ad esempio visitando i campi profughi dei siriani. Era un grande tifoso di basket, sosteneva i Miami Heat negli ultimi anni dominatori della Nba, e sul suo profilo Twitter si definiva “un filosofo da cabaret di Miami”.
Solo qualche giorno fa sua madre aveva girato un video appello per liberarlo.